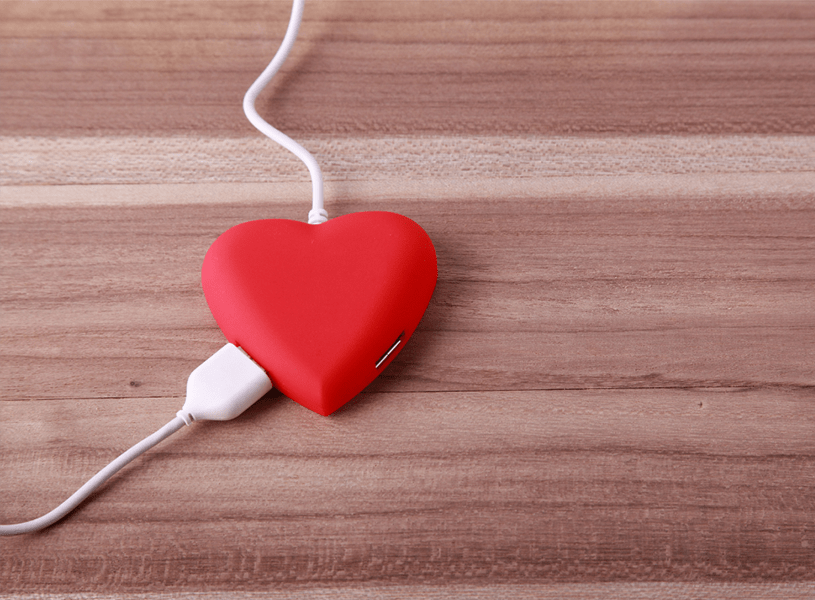In quest’articolo l’educatrice e pedagogista Francesca Doni prende in esame alcune criticità che in molti casi gli educatori incontrano all’inizio o durante il loro percorso professionale in RSA. Una riflessione che aiuta a diffondere consapevolezza sulla realtà pratica della professione e su alcune lacune ancora presenti a livello di sistema.
Le sfide per l’educatore in RSA
Le sfide che un educatore si trova ad affrontare all’interno di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) sono molteplici. Alcune possono essere superate attraverso l’erogazione di una formazione specifica, una supervisione regolare e un pizzico di creatività; altre, invece, richiedono interventi di tipo strutturale e legislativo.
Per comprendere meglio queste difficoltà, ritengo sia utile partire dall’inizio, ovvero dal momento in cui un educatore inizia il proprio percorso professionale in RSA. A tal proposito, farò riferimento alla mia esperienza personale da educatrice di una struttura che può ospitare fino a 156 persone, arricchita dalle testimonianze di colleghi raccolte negli anni attraverso i social network.
Alla ricerca di formazione specifica in ambito geriatrico
La prima grande sfida che ho incontrato, iniziando a lavorare in RSA, è stata la mancanza di una formazione specifica per operare con la popolazione anziana.
Come instaurare una relazione con una persona affetta da deterioramento cognitivo?
Quali sono i cambiamenti biopsicosociali che caratterizzano l’anziano nel processo di invecchiamento?
Quali bisogni emergono con l’avanzare dell’età e come è possibile, oltre che doveroso, rispondere adeguatamente a tali necessità?
Questi sono solo alcuni dei quesiti che un educatore si pone all’inizio della sua carriera in RSA.
Va rilevato che, ad oggi, in Italia sono ancora pochi i corsi di laurea in Educazione Professionale e Scienze dell’Educazione che dedicano uno o più insegnamenti specifici all’ambito geriatrico.
Molti educatori, di conseguenza, si trovano ad intraprendere questo percorso professionale senza una preparazione adeguata, rischiando così di commettere errori che potrebbero incidere negativamente sul benessere delle persone anziane a loro affidate.
Fortunatamente, questo primo ostacolo può essere superato grazie a una formazione specifica sul campo. Tuttavia, ciò è possibile solo se si ha la fortuna di lavorare presso enti che investono nella formazione del proprio personale, oppure se si dispone di risorse economiche sufficienti per provvedere autonomamente a colmare tale lacuna.
Alla ricerca di riconoscimento professionale
La seconda sfida che, a mio avviso, contraddistingue il lavoro educativo all’interno delle RSA è il limitato riconoscimento professionale.
Sebbene abbia già trattato questo argomento in precedenti occasioni, ritengo necessario sottolinearne ancora una volta la rilevanza, poiché rappresenta un problema tuttora diffuso, sia all’interno delle équipe di cura che all’esterno.
Molti professionisti, caregiver e stakeholder che, a vario titolo, gravitano attorno alle strutture di cura non comprendono pienamente il ruolo dell’educatore in questo contesto, relegandolo spesso a una posizione di “secondo piano”.
Pur non essendo una situazione comune a tutte le persone e a tutte le realtà, in alcuni contesti questa dinamica esiste e può influire negativamente sulla qualità del lavoro degli educatori, che si trovano a operare senza il necessario sostegno dei colleghi e senza essere riconosciuti al pari di altre figure professionali dai caregiver.
Tale situazione può generare sconforto e frustrazione, e con il tempo può persino condurre al burnout.
Anche in questo caso, tuttavia, è possibile adottare strumenti e strategie che permettano di aggirare tali difficoltà. In un precedente articolo, ho esaminato nel dettaglio le azioni che l’educatore può intraprendere dall’interno per uscire dall’isolamento professionale in cui viene spesso confinato.
È altrettanto fondamentale, però, che anche le organizzazioni si impegnino attivamente, promuovendo una cultura organizzativa volta a valorizzare tutte le figure che compongono l’équipe. Solo così sarà possibile garantire un riconoscimento professionale equo e rispettoso per tutti i professionisti coinvolti.
Alla ricerca di tempo
La terza sfida, condivisa dalla maggior parte degli educatori di RSA con cui mi interfaccio sui social network e che personalmente mi trovo ad affrontare quotidianamente, riguarda la gestione del tempo.
Il tema del minutaggio è da tempo oggetto di dibattito nel settore sociosanitario, coinvolgendo tutti i professionisti dell’équipe di cura. La tematica del tempo continua a rappresentare una questione cruciale nella vita quotidiana, poiché come recitava il titolo del Meeting delle Professioni di Cura 2024: “Non c’è cura nella fretta”.
Prima di approfondire questo argomento, ritengo necessario sottolineare l’importanza di considerare il concetto di “tempo” da due prospettive distinte.
Da un lato, gli anziani vivono un tempo spesso percepito come lento e dilatato, spesso svuotato di ruoli e occupazioni significative. Dall’altro, gli operatori affrontano un tempo frenetico, scandito da ritmi serrati che lasciano poco spazio alla costruzione di relazioni significative.
Questa discrepanza temporale riguarda tutti i professionisti dell’équipe, ma colpisce in particolar modo gli educatori, spesso assunti con contratti part-time e pertanto limitati a dedicare soltanto 2 o 3 ore al giorno alla relazione educativa.
Pur avendone già parlato in un precedente articolo, ritengo fondamentale ribadire che la complessità del lavoro educativo non può essere confinata in un intervento limitato a poche ore giornaliere, all’interno di un contesto ampio e di gruppo. La relazione educativa ha bisogno di tempo per svilupparsi, maturare e produrre risultati significativi.
Inoltre, gli anziani, a causa del naturale rallentamento delle proprie capacità fisiche e cognitive, necessitano di un tempo maggiore per potersi relazionare ed esprimere.
Questo ulteriore aspetto rende ancora più evidente l’importanza di un approccio educativo che tenga conto dei loro ritmi e delle loro esigenze, valorizzando il tempo come risorsa essenziale per instaurare una relazione autentica e significativa.
La distanza tra leggi e realtà
Per concludere, come sottolineato in una puntata del podcast Semi di cura, nonostante la legge 219 del 2017 abbia formalmente riconosciuto la relazione come parte integrante del tempo di cura, le normative attuali sono ancora lontane dal prevedere minutaggi adeguati a rispondere ai reali bisogni degli anziani e degli operatori.
Questa distanza tra legislazione e pratica quotidiana continua a rappresentare una delle sfide più rilevanti nel contesto dell’assistenza sociosanitaria, rendendo necessario un intervento normativo che valorizzi il tempo relazionale come elemento fondamentale della cura.
PERSONE
Eventi e Cultura

Semi di CURA
NEWSLETTER
Esiste un significato profondo nel lavoro di CURA e una ricchezza nascosta in RSA?
La newsletter
«Semi di CURA»
indaga questo e lo racconta ogni ultimo venerdì del mese.
In quest’articolo l’educatrice e pedagogista Francesca Doni prende in esame alcune criticità che in molti casi gli educatori incontrano all’inizio o durante il loro percorso professionale in RSA. Una riflessione che aiuta a diffondere consapevolezza sulla realtà pratica della professione e su alcune lacune ancora presenti a livello di sistema.
Le sfide per l’educatore in RSA
Le sfide che un educatore si trova ad affrontare all’interno di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) sono molteplici. Alcune possono essere superate attraverso l’erogazione di una formazione specifica, una supervisione regolare e un pizzico di creatività; altre, invece, richiedono interventi di tipo strutturale e legislativo.
Per comprendere meglio queste difficoltà, ritengo sia utile partire dall’inizio, ovvero dal momento in cui un educatore inizia il proprio percorso professionale in RSA. A tal proposito, farò riferimento alla mia esperienza personale da educatrice di una struttura che può ospitare fino a 156 persone, arricchita dalle testimonianze di colleghi raccolte negli anni attraverso i social network.
Alla ricerca di formazione specifica in ambito geriatrico
La prima grande sfida che ho incontrato, iniziando a lavorare in RSA, è stata la mancanza di una formazione specifica per operare con la popolazione anziana.
Come instaurare una relazione con una persona affetta da deterioramento cognitivo?
Quali sono i cambiamenti biopsicosociali che caratterizzano l’anziano nel processo di invecchiamento?
Quali bisogni emergono con l’avanzare dell’età e come è possibile, oltre che doveroso, rispondere adeguatamente a tali necessità?
Questi sono solo alcuni dei quesiti che un educatore si pone all’inizio della sua carriera in RSA.
Va rilevato che, ad oggi, in Italia sono ancora pochi i corsi di laurea in Educazione Professionale e Scienze dell’Educazione che dedicano uno o più insegnamenti specifici all’ambito geriatrico.
Molti educatori, di conseguenza, si trovano ad intraprendere questo percorso professionale senza una preparazione adeguata, rischiando così di commettere errori che potrebbero incidere negativamente sul benessere delle persone anziane a loro affidate.
Fortunatamente, questo primo ostacolo può essere superato grazie a una formazione specifica sul campo. Tuttavia, ciò è possibile solo se si ha la fortuna di lavorare presso enti che investono nella formazione del proprio personale, oppure se si dispone di risorse economiche sufficienti per provvedere autonomamente a colmare tale lacuna.
Alla ricerca di riconoscimento professionale
La seconda sfida che, a mio avviso, contraddistingue il lavoro educativo all’interno delle RSA è il limitato riconoscimento professionale.
Sebbene abbia già trattato questo argomento in precedenti occasioni, ritengo necessario sottolinearne ancora una volta la rilevanza, poiché rappresenta un problema tuttora diffuso, sia all’interno delle équipe di cura che all’esterno.
Molti professionisti, caregiver e stakeholder che, a vario titolo, gravitano attorno alle strutture di cura non comprendono pienamente il ruolo dell’educatore in questo contesto, relegandolo spesso a una posizione di “secondo piano”.
Pur non essendo una situazione comune a tutte le persone e a tutte le realtà, in alcuni contesti questa dinamica esiste e può influire negativamente sulla qualità del lavoro degli educatori, che si trovano a operare senza il necessario sostegno dei colleghi e senza essere riconosciuti al pari di altre figure professionali dai caregiver.
Tale situazione può generare sconforto e frustrazione, e con il tempo può persino condurre al burnout.
Anche in questo caso, tuttavia, è possibile adottare strumenti e strategie che permettano di aggirare tali difficoltà. In un precedente articolo, ho esaminato nel dettaglio le azioni che l’educatore può intraprendere dall’interno per uscire dall’isolamento professionale in cui viene spesso confinato.
È altrettanto fondamentale, però, che anche le organizzazioni si impegnino attivamente, promuovendo una cultura organizzativa volta a valorizzare tutte le figure che compongono l’équipe. Solo così sarà possibile garantire un riconoscimento professionale equo e rispettoso per tutti i professionisti coinvolti.
Alla ricerca di tempo
La terza sfida, condivisa dalla maggior parte degli educatori di RSA con cui mi interfaccio sui social network e che personalmente mi trovo ad affrontare quotidianamente, riguarda la gestione del tempo.
Il tema del minutaggio è da tempo oggetto di dibattito nel settore sociosanitario, coinvolgendo tutti i professionisti dell’équipe di cura. La tematica del tempo continua a rappresentare una questione cruciale nella vita quotidiana, poiché come recitava il titolo del Meeting delle Professioni di Cura 2024: “Non c’è cura nella fretta”.
Prima di approfondire questo argomento, ritengo necessario sottolineare l’importanza di considerare il concetto di “tempo” da due prospettive distinte.
Da un lato, gli anziani vivono un tempo spesso percepito come lento e dilatato, spesso svuotato di ruoli e occupazioni significative. Dall’altro, gli operatori affrontano un tempo frenetico, scandito da ritmi serrati che lasciano poco spazio alla costruzione di relazioni significative.
Questa discrepanza temporale riguarda tutti i professionisti dell’équipe, ma colpisce in particolar modo gli educatori, spesso assunti con contratti part-time e pertanto limitati a dedicare soltanto 2 o 3 ore al giorno alla relazione educativa.
Pur avendone già parlato in un precedente articolo, ritengo fondamentale ribadire che la complessità del lavoro educativo non può essere confinata in un intervento limitato a poche ore giornaliere, all’interno di un contesto ampio e di gruppo. La relazione educativa ha bisogno di tempo per svilupparsi, maturare e produrre risultati significativi.
Inoltre, gli anziani, a causa del naturale rallentamento delle proprie capacità fisiche e cognitive, necessitano di un tempo maggiore per potersi relazionare ed esprimere.
Questo ulteriore aspetto rende ancora più evidente l’importanza di un approccio educativo che tenga conto dei loro ritmi e delle loro esigenze, valorizzando il tempo come risorsa essenziale per instaurare una relazione autentica e significativa.
La distanza tra leggi e realtà
Per concludere, come sottolineato in una puntata del podcast Semi di cura, nonostante la legge 219 del 2017 abbia formalmente riconosciuto la relazione come parte integrante del tempo di cura, le normative attuali sono ancora lontane dal prevedere minutaggi adeguati a rispondere ai reali bisogni degli anziani e degli operatori.
Questa distanza tra legislazione e pratica quotidiana continua a rappresentare una delle sfide più rilevanti nel contesto dell’assistenza sociosanitaria, rendendo necessario un intervento normativo che valorizzi il tempo relazionale come elemento fondamentale della cura.